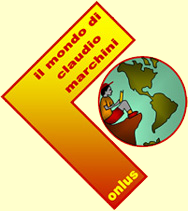Il Papa, nel documento sulla vita religiosa, Vita consecrata 93, afferma: “la vita spirituale, intesa come vita in Cristo, vita secondo lo Spirito, si configura come un itinerario di crescente fedeltà, in cui la persona consacrata è guidata dallo Spirito e da lui configurata a Cristo, in piena comunione di amore e di servizio nella Chiesa”. La vita di fede, nella visuale del Papa, per dirla con un’immagine, non è una carta geografica, ma un cammino sul terreno. La vita cristiana, soprattutto nella persona consacrata, è un itinerario volto a favorire il passaggio da una fede superficiale e di consuetudine, a una fede capace di coinvolgere la totalità dell’esistenza credente. In questo passaggio la vita di consacrazione può esprimere tutta la sua radicalità e divenire, al tempo stesso, una “risorsa” beatitudinale e profetica.
1. Aspetti problematici della sequela di Cristo oggi
Per meglio entrare nel discorso, mi pare opportuno evidenziare alcuni momenti problematici che oggi assume la sequela di Cristo e in particolare la sequela di Cristo vissuta nella consacrazione.
Spiritualità centrata troppo sull’etica e poco sulla mistica
La sequela, spesso, è fondata su una spiritualità della pratica che la rende alquanto statica. Per sua natura, il discepolato cristiano è un incontro personale con il Signore vivente, un’amicizia con lui che non può mai essere ridotta a una semplice messa in pratica di leggi e di comandamenti. Certamente quest’ultimo aspetto è insito nel cammino di fede ma, quando prende il sopravvento, c’è il pericolo di far ricadere l’avventura cristiana in una dimensione puramente etica, che rischia di porre in ombra la peculiarità comunionale della stessa. La sopravvalutazione della dimensione “etica” rischia di sottovalutare la valenza mistica e, di conseguenza, mettere in ombra la stessa relazione con Dio, principio della vita cristiana.
Spiritualità troppo “formale” e poco “radicale”
Un secondo aspetto problematico è la formalità con cui, spesso, viene vissuta l’esperienza di consacrazione. Potrebbe anche apparire curioso per l’ambiente ecclesiale, eppure lo stesso C.G. Jung, già diversi anni fa, aveva intravisto, con estrema chiarezza, questa possibile deriva dell’esperienza cristiana. Egli parlava di due poli nell’esperienza della fede cristiana: la fede legittima e quella che riposa esclusivamente nell’autorità della tradizione, senza un’adesione personale. Mi sembrano ancora attuali le sue osservazioni:
“La fede legittima risale sempre all’esperienza vissuta. Accanto a questa esiste una fede che riposa esclusivamente sull’autorità della tradizione. Si può chiamare anche questa fede legittima, in quanto anche la forza della tradizione rappresenta un’esperienza la cui importanza per la continuità della cultura è fuori discussione. Certo in questa forma di fede è inserito il pericolo di divenire una mera abitudine, un’inerzia spirituale, una comoda osservanza priva di pensiero che minaccia di determinare un arresto e quindi un regresso nella cultura. Questa dipendenza divenuta meccanica procede di pari passo con la regressione psichica verso l’infantilismo, in quanto i contenuti tradizionali perdono a poco a poco il loro vero significato e viene loro tributata solo una fede formale, senza che questa fede possegga un’influenza qualsiasi sulla vita. Dietro di essa non vi è più potenza vitale”.
Una fede non personalizzata rischia di diventare una regressione semplicemente infantile.
Spiritualità incentrata troppo sulla “perfezione” e poco sulla “bontà”
Può darsi che nei nostri ambienti e nella nostra formazione l’attenzione si sia maggiormente portata sul raggiungimento della perfezione, intesa come nostro sforzo e nostra conquista. Abbiamo, forse, dimenticato che la perfezione evangelica è la “bontà”. Afferma p. Tillard:
“Il Cristo è venuto a liberare il fondo di bontà dell’uomo, che il male non è in grado di distruggere. La bontà esiste, il male non è affatto destinato ad avere l’ultima parola. La Chiesa è incaricata dallo Spirito di rivelare, risvegliare e sprigionare la bontà che dorme nel cuore umano. Qui s’inscrive il progetto della vita religiosa. Essa mira a liberare il fondo di bontà della persona e a renderne testimonianza per Dio… Povertà, castità, obbedienza hanno questo obiettivo. Cercare la “perfezione evangelica” è cercare la Bontà, che impregna da ogni parte la visita di Dio in Cristo Gesu”.
Spiritualità troppo centrata sull’autorealizzazione e poco sulla “comunione”
Nella vita cristiana il cammino di “autorealizzazione” si concretizza nella “comunione”. La libertà ci è donata, perché l’amore si compia “fino alla fine” (cf Gv 13,1). Mi pare che oggi, tra noi consacrati, il bisogno di autorealizzazione ha preso il posto della comunione. L’altro rischia di essere considerato più come uno “strumento” della mia personale realizzazione, che una persona con cui condividere un cammino di discepolato, di fraternità e di servizio.
2. Il cammino di appropriazione personale della vita di fede
Per accogliere l’invito di Giovanni Paolo II che chiama a riscoprire la vita cristiana come un itinerario e tentare di rispondere in positivo alle quattro “stretture” problematiche della sequela di Cristo oggi, in cui si dibatte la stessa donna consacrata, è necessario un passaggio fondamentale che sembra riguardare maggiormente il mondo dei fedeli laici, ma che coinvolge direttamente uomini e donne consacrate, che hanno donato la loro esistenza a Cristo, in una sequela radicale e in un servizio disinteressato ai fratelli. Diceva Giovanni Paolo II nel discorso rivolto ai Vescovi lombardi in visita ad limina nel 1991:
“(Nella situazione in cui vive oggi il cristiano e il cristiano consacrato), occorre soprattutto il passaggio da una fede di consuetudine, pur apprezzabile, a una fede che sia scelta personale, illuminata, convinta, testimoniante. È il tempo della nuova evangelizzazione”. E ancora: “Solo l’effettiva riscoperta di Cristo quale solida roccia su cui costruire la vita e l’intera società permette ai credenti di non temere difficoltà e ostacoli di ogni tipo”.
Secondo il Papa, una possibile via, per tentare di superare le difficoltà odierne del vivere cristiano, consiste nell’aprire il cuore a Cristo, impegnandoci a passare da una fede di consuetudine, vissuta per inerzia o per abitudine, a un’esistenza cristiana fondata su una scelta di fede personale, illuminata, convinta, testimoniante. Ma come favorire questo transito esodale da una fede semplicemente saputa a un’esistenza cristiana interamente vissuta? Una strada potrebbe consistere nel sollecitare l’appropriazione personale dell’esistenza cristiana, ossia nel favorire l’appropriazione personale della sequela di Cristo Signore. Il cristiano laico, né tanto meno l’uomo o la donna consacrata, può oggi accontentarsi di vivere l’esistenza di fede con tiepidezza e formalità, ricercando una perfezione vuota e astratta, centrata sulla pratica, oppure esprimere un cammino spirituale come momento parallelo ad altre esperienze di vita. Oggi più che mai è necessario sottolineare che la sequela di Gesù, per sua stessa natura, è una chiamata che tende a prendere forma, nel tempo e nello “spazio” personale, ecclesiale e storico, attraverso un processo di appropriazione personale. Il termine appropriazione deriva da proprius e significa ciò che mi appartiene, ciò che mi riguarda personalmente e direttamente. Appropriazione personale, qui, si riferisce al fare mia un’idea, un ideale, un atteggiamento, uno stile di vita, un valore, una verità, in modo che tutta la mia esistenza ne sia coinvolta. In questo quadro, appropriarsi dell’esistenza cristiana significa porre concretamente in evidenza l’esistere personalmente nel mistero di Dio che, in Cristo per lo Spirito, si impegna per me, per tutti gli uomini, per il mondo intero. Appropriarsi dell’esistenza cristiana significa aprirsi all’esperienza che già fu dell’apostolo Paolo: “Colui che mi ha scelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato con la sua grazia si compiacque di rivelare in me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani” (cf Gal 1,15-16). Il Padre si degna di rivelare, per mezzo dello Spirito, suo Figlio nel cuore del cristiano, perché lo annunci al mondo. In definitiva, appropriarsi del cammino di fede, “significa abituarsi a dare una risposta personale alla questione fondamentale di Cristo: mi ami tu?”.
Afferma Edith Stein: “Grande distanza corre tra l’essere soddisfatti di sé ritenendosi “buon cattolico” che “fa il suo dovere”, e l’abbandono totale del Figlio di Dio, che ha affidato la propria vita al Padre e cammina con lui, mano nella mano, tutto aspettando da lui, con la semplicità del bambino e l’umiltà del pubblicano. Una volta che l’anima ha percorso quella distanza, non può più tornare indietro”. L’esperienza cristiana non può farsi per sentito dire. O come parallela o addirittura marginale alla vita quotidiana. La sequela cristiana è l’appello del Padre rivolto “a me” nel Figlio suo che, per lo Spirito, diviene la “mia” perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo del “mio” cuore e che si esplicita e si invera in esistenza ecclesiale e storica, in esperienza di comunione e di bontà. A questo proposito è decisamente istruttiva l’esperienza di Giobbe, grande amico di Dio. Egli, nello scorrere della sua vita, intuisce gli attributi divini ed esprime il suo assenso nozionale verso la giustizia, la verità, la bontà, la misericordia di Dio. Le vicissitudini della sua esistenza, tuttavia, contribuiscono a trasformare il suo “assenso nozionale” in assenso reale, ossia, in autentica e profonda appropriazione personale. Al termine del suo cammino, rivolto a Dio, esclama: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere” (Gb 42,5-6).
L’appropriazione personale, secondo l’esperienza di Giobbe, è il passaggio dal “sentito dire” al “vedere con i propri occhi”. Nella sequela del suo Signore, la donna consacrata è chiamata, oggi, a fare il medesimo passaggio: dal “sentito dire” al “vedere con i propri occhi”; è chiamata a cercare “Gesù per Gesù”. Al termine del Giubileo, Giovanni Paolo II non esita a porre la santità a fondamento della programmazione pastorale. Compiere questo passo è una scelta gravida di conseguenze: “Significa esprimere la convinzione che, se il Battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio, attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’insegna di un’etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno: “Vuoi ricevere il Battesimo?” significa al tempo stesso chiedergli: “Vuoi diventare santo?”. Significa porre sulla sua strada il radicalismo del discorso della Montagna: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5,48)” (NMI 31). Se così devono essere i catecumeni, figuriamoci le donne consacrate…
3. Percorsi per favorire l’appropriazione della propria consacrazione
Per dare valore e concretezza al cammino di appropriazione è, quanto mai opportuno, tentare di intravedere qualche percorso che possa aiutare la donna consacrata a passare dal “sentito dire” al “vedere con i propri occhi”, a fare “esodo” da un’esistenza religiosa vissuta per consuetudine o “senza infamia e senza lode”, a una sequela radicale di Cristo Signore. Per compiere questo passaggio è necessario che ciascuno accolga con radicalità il dono spirituale che gli è consegnato nel Battesimo e nella consacrazione. In questo orizzonte intendo tracciare quattro itinerari che aiutino a cogliere la forza dirompente che la vita evangelica trattiene per ciascuno di noi, per la Chiesa e per il mondo intero.
3.1. Premessa ai percorsi: l’uomo immagine e somiglianza del Dio Trinità
La Bibbia ci informa, già nella prima pagina della Genesi, che l’uomo è un essere creato a immagine e somiglianza di Dio. Essere immagine e somiglianza di Dio, per l’uomo, significa due cose. Anzitutto, che egli è reso signore del creato, a immagine di Dio, esclusivo Signore dell’uomo e del cosmo. E poi, che partecipa della vita stessa del Dio Trinità, attraverso Cristo e lo Spirito Santo. In quanto creato “a immagine” di Dio, l’uomo non ha fondamento in sé, ma il suo è un “essere-in-comunione-con-Dio-Trinità”. Questo significa che tutta la ricchezza dell’uomo, la sua sensibilità, la sua psiche, la sua ragione, il suo cuore, in una parola, tutto il suo essere è creato in maniera da essere affine a Dio. La natura umana, pur creata e corruttibile, essendo affine a Dio porta in sé il germe dell’eternità, ha in sé una profondissima nostalgia di Dio. Perciò, se vogliamo comprendere qualcosa dell’uomo, dobbiamo partire da Dio. Non è possibile comprendere l’uomo rimanendo in lui, chiudendosi in lui, perché l’uomo non è fondamento di se stesso. Per intendere l’uomo è necessario “sostare” in Dio. La grande tradizione patristica è un invito costante a partire dal Dio Trinità per balbettare qualcosa dell’uomo. In questo modo, ciò che diciamo di Dio possiamo dirlo anche dell’uomo, proprio in quanto creato “a sua immagine”. In questa prospettiva è possibile cogliere la densità “divina” della nostra consacrazione, che, conducendoci nel mistero stesso del Dio Trinità, ci permette di cogliere la radicalità del fondamento e di esplorare alcuni percorsi, che possono farsi “risorsa” per tutti i consacrati, in particolare per la donna credente. Proviamo a sondare alcuni di questi percorsi.
3.2. Dio Trinità è persona e koinônía, l’uomo è persona e koinônía
La prima realtà, che possiamo affermare del Dio di Gesù, è che egli è un Dio Trinità. Il Dio Trinità, che Cristo Gesù ci ha rivelato, è persona e koinônía (comunione) in maniera perfetta. Solo per il fatto che la Trinità Santa è koinônía di persone, ciascuno dei tre – Padre, Figlio e Spirito Santo – è, per eccellenza, persona e, come persone, i tre vivono la koinônía dell’unica divinità. Padre, Figlio e Spirito Santo sono dei nomi che trattengono delle relazioni. Non posso dire Padre senza che vi sia un Figlio, non posso dire Figlio senza che vi sia un Padre, non posso dire Spirito Santo senza pensare al “vincolo”, al “luogo divino” dove il Padre e il Figlio si uniscono e si ritrovano. Detto in altri termini, il Dio Trinità è “persona in comunione”, è “koinônía di persone”. La teologia dell’Oriente cristiano presenta la Trinità come una grande danza. I tre non solo danzano uno accanto all’altro, ma danzano “uno nell’altro”. In questo senso il Dio Trinità è persona e comunione, persone “in” comunione. Il mistero che affermiamo del Dio Trinità, possiamo dirlo anche dell’uomo. L’uomo, in quanto creato a immagine della Trinità Santa, koinônía di persone, è anch’egli “persona e koinônía”, o meglio “persona in koinônía”. Un uomo considerato esclusivamente nella sua “solitudine” non sarebbe immagine somigliante del Dio Trinità. Per questo, è Dio stesso a creare la donna, a donarla al maschio come “aiuto” o, più esattamente, come un “di-fronte”. “L’uno verso l’altra”, “l’uno di-fronte all’altra”, maschio e femmina formano dal principio l’immagine. La venuta di Eva realizza l’ecclesialità sponsale del maschio e della donna; dice la Genesi: “Questa si chiamerà Isha donna, perché fu creata da Ish uomo” (cf Gn 2,23). Commenta san Cirillo d’Alessandria: “Dio, in quell’istante, creò il co-essere”. Ora, quando si afferma che la persona è comunione, si intende sottolineare la dimensione relazionale io-tu o io-tu-noi. La persona umana è certamente koinônía in questo senso. Eppure, a ben vedere, perché questa stessa dimensione comunionale si affermi, è necessario che l’uomo sia koinônía, anzitutto, nel proprio sé. Il riflesso trinitario, che l’uomo esprime, dice che egli è “co-essere” fin dal principio, fin nella sua profondità. Per comprendere l’uomo, allora, è necessario passare dall’individuo alla persona. L’individuo, su cui la nostra cultura occidentale pone molto l’accento, si regge sulla sua soggettività, sul suo io, sul suo sé: è una “monade”, come direbbe qualcuno. La persona, al contrario, è sé e Altro/altro insieme. Per colui che si riconosce persona, l’altro non è solo accanto a lui, al suo fianco, ma è già in lui. Se io sono un “co-essere”, l’altro è già in me prima che si sieda al mio fianco; è già in me a prescindere da come lo tratto, da come lo ami, da come lo odi o gli sia indifferente. Nel momento in cui “io” mi considero persona, immagine della Trinità, io non sono più un semplice “io”, un “io indiviso”, un “io individuo”. In me c’è una società di persone che hanno bisogno l’una dell’altra, che si dividono l’una con l’altra, che fanno la guerra o vivono la pace l’una nei confronti dell’altra.
Questo modo di concepire la persona, è, anzitutto, a fondamento della Chiesa intesa come corpo del Signore (cf 1Cor 12-14). L’altro, per l’azione dello Spirito Santo, è già presente nel mio “co-essere”, già si affaccia nella mia carne, nella mia psiche, nel mio cuore, prima di incontrarlo “faccia a faccia”. Anzi, io posso incontrare l’altro “faccia a faccia”, proprio perché l’altro è già in me. La “persona in koinônía” ha pure un risvolto sociale e politico, un risvolto di “politica alta”. In un dibattito tra il Card. Martini e Massimo Cacciari sulla solidarietà verso i diversi, in particolare verso gli stranieri, Cacciari fa un’affermazione che dovrebbe far molto pensare noi cristiani che, a volte, rischiamo di farci paladini della solidarietà solo a parole: “Io non posso ignorare l’altro perché io sono l’altro, perché io mi sono straniero. Io posso riconoscere lo straniero in quanto tale, perché io lo conosco in me; non potrei predicarlo fuori di me, riconoscerlo fuori di me. Questo rapporto di alterità con un altro fuori di me è possibile trascendentalmente, perché l’altro è il mio socio essenziale, colui dal quale non posso distaccarmi – me stesso”. La donna consacrata è chiamata alla profezia della “persona in koinônía” nella Chiesa e nel mondo di oggi. Quanto più essa, come del resto ogni cristiano, si sperimenta come un co-essere a immagine della Trinità, tanto più si esprime in koinônía: “piccola sorella universale”; testimone di bontà verso l’altro, in particolare verso i piccoli, i poveri, gli stranieri; membra vive della sua piccola comunità. Tutto questo è possibile perché uomo e donna sono “insieme” immagine e somiglianza del Dio tre volte santo. La contemplazione del Dio Trinità è espressione concreta di comunione in se stessi, nella Chiesa e nel mondo. Questo significa passare da un assenso nozionale al dogma della Trinità, a un assenso reale al Dio rivelato da Gesù, Dio trino e uno, comunità di persone e unità ineffabile. Il nostro rapporto con la Trinità Santa si fa vita e risorsa.
3.3. Dio Trinità è essenzialmente libero, l’uomo è creatura libera
Il Dio, che Gesù ci rivela, possiede un’altra caratteristica fondamentale, a cui noi cristiani poniamo poca attenzione. Se il Dio Trinità è comunione e Amore, egli è essenzialmente libero. Non si dà, infatti, amore senza libertà. Un amore costretto non è più amore. Il Dio Trinità è libero in sommo grado, perché è niente altro che Amore e comunione. L’uomo, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio, partecipa della stessa libertà del Dio Trinità. L’uomo, afferma Ireneo di Lione, è costituito “libero e signore della propria vita”. Certamente, la libertà, che ciascuno di noi esprime, è una libertà offuscata e contrastata da molti limiti, in particolare dall’egoismo del nostro peccato. Eppure, la libertà radicata nell’immagine di Dio, anche se si oscura, non può essere mai soppressa. Secondo i Padri della Chiesa, interpreti profondi della Bibbia, con il peccato Adamo ha perduto la somiglianza, ma non l’immagine. Il Cristo con la sua incarnazione, morte e risurrezione è venuto a ridonarci la somiglianza perduta. Questa, allora, diviene per noi come una possibilità, un’energia da mettere in opera, per ritrovare la via verso l’autentica libertà che, nel più profondo di noi, attende di manifestarsi. Nell’uso corretto della nostra libertà Dio Padre non ci lascia soli, ma ci offre le sue due mani, ossia il Figlio e lo Spirito. Se ci aggrappiamo a queste due mani e cooperiamo con esse, ciascuno assumerà, gradualmente, quella forma che Dio stesso ha pensato da sempre per la nostra perfetta beatitudine. Afferma stupendamente Ireneo di Lione: “Non sei tu che fai Dio, ma Dio che fa te. Se dunque tu sei l’opera di Dio, attendi la mano dell’Artista, che fa ogni cosa al momento opportuno nei confronti tuoi, che sei l’oggetto modellato. Presentagli un cuore flessibile e adattabile e conserva la forma che l’Artista ti ha dato. Nel mantenere questa conformità, salirai fino alla perfezione, perfezione perché l’arte di Dio nasconderà l’argilla in te. La sua Mano, che ha creato la tua sostanza ti rivestirà d’oro puro e d’argento di dentro e di fuori e ti adornerà così bene che il Re stesso si lascerà prendere dalla tua bellezza”. L’uomo è l’opera perfetta e luminosa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Egli, tuttavia, è chiamato a rendere questa immagine perfettamente rassomigliante inventando, per il soffio e il fuoco dello Spirito, un modo incomparabilmente personale di essere in Cristo. Tale “invenzione” l’uomo l’attualizza nella libertà, affidando alle mani di Dio tutto ciò che è suo. È, soprattutto, nei momenti difficili, nelle svolte fondamentali della vita, che siamo chiamati a inventare il cammino di libertà, cooperando con le “due mani” che Dio Padre ci offre.
Un fatto biblico può aiutarci a comprendere. Il profeta Daniele racconta di tre giovani che furono gettati nel fuoco ardente perché si erano rifiutati di rinnegare il Dio di Israele per aderire agli dei del re di Babilonia. I tre giovani, tuttavia, come nota la Bibbia, “passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore” (cf Dn 3,24). Un angelo del Signore, che era sceso con loro nella fornace, “allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l’interno della fornace come un luogo dove soffiava un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia” (cf Dn 3,49s). E i tre intonarono l’inno che ancora oggi si canta nelle lodi mattutine della Domenica. Ciò che contraddistingue questi tre giovani è la loro libera e fiduciosa adesione a Dio. Decidendo di rimanere saldi in Dio, riescono a non farsi arrecare danno dalla situazione decisamente sfavorevole. Anziché darsi al lamento, la loro fede in Dio li apre ad un giusto atteggiamento nei confronti della patria, del denaro offerto dal re, della loro libertà interiore. La loro è una lezione anche per noi. Se io getto liberamente la mia áncora in Dio, nemmeno il fuoco può farmi del male. Stando con Dio, posso guardare ogni evento con più profondità, con più pace, con più forza. Aggrappandomi a Dio, posso accogliere l’attrattiva della mia sensibilità, l’energia della mia passione, la seduzione del mio intelletto, l’abisso del mio cuore e ancorarle nella profondità del mio spirito, là dove posso viverle in amichevole dialogo con il Cristo e con lo Spirito. Questo cammino è “via” verso la libertà radicata nell’immagine. Quanto più sono ancorato a Cristo, tanto più sono libero dal principe di questo mondo, dal potere dei re della terra, dal potere di tante persone, di tanti “grandi vecchi” che pensano di poter decidere della mia vita e poter determinare il mio futuro. La mia piccola, ma libera adesione a Cristo, si muove verso quella libertà che i tre giovani hanno dimostrato di possedere dinanzi al re e alle sue lusinghe. La donna consacrata è chiamata alla profezia della libertà in un quotidiano sempre più standardizzato e limitante.
3.4. Il Dio Trinità ama “follemente” l’uomo
Ponendoci dalla parte di Dio, nella considerazione dell’uomo possiamo scoprire una terza fondamentale caratura della vita cristiana: l’uomo è una persona amata da Dio: dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. È certamente vero che, sulla scia di Adamo, anche noi viviamo con difficoltà l’amore e la libertà. Ma un tale processo di degrado non è definitivo. Il Verbo di Dio, immagine del Padre, con la sua Incarnazione, morte, risurrezione e glorificazione, ri-crea nell’uomo, per l’energia dello Spirito, la veste luminosa dell’immagine somigliante e gli ridona la pienezza della libertà agapica, quella libertà che scaturisce dalla carità. Così, nel dono di Cristo, nel suo amore per noi infinito e sacrificale “fino alla morte di croce” (cf Fil 2,8), l’uomo è liberato dalla schiavitù di Satana e può tornare, per lo Spirito e nella libertà, a partecipare alla vita divina, alla quale Dio Padre da sempre l’aveva destinato. Nell’opera del Cristo, infatti, l’uomo può vedere “la rivelazione della grande carità di Dio”. La misericordia e la compassione del Padre superano infinitamente la cattiveria dell’uomo. Per quanto l’uomo possa essere ingrato, la sua azione avrà sempre una portata limitata; invece, la misericordia del Padre rimarrà infinitamente superiore e capace, nella sua onnipotenza, di superare il negativo che esiste nell’uomo. La tradizione dell’Oriente e dell’Occidente cristiano ha molto insistito sull’amore “folle” di Dio verso l’uomo. Ascoltiamo in proposito le parole di Nicola Cabasilas, teologo laico del sec. XIV: “Dio, per darci l’esperienza del suo grande amore e mostrare che ci ama di un amore senza limiti, inventa il suo annientamento, lo realizza e fa in modo di divenire capace di soffrire e di patire cose terribili. Così, con tutto quello che sopporta, Dio convince gli uomini del suo straordinario amore per loro e li attira nuovamente a sé, essi che fuggivano il Signore buono credendo di essere odiati. La cosa più straordinaria è tuttavia che non solo tollerò di patire le cose più terribili e di morire coperto di piaghe, ma che, anche risorto, dopo aver risollevato il corpo dalla corruzione, si cinge ancora di queste ferite, ne porta sul corpo le cicatrici e così appare agli occhi degli angeli, le considera un ornamento e si compiace di mostrare che ha sofferto orribilmente. Egli ha ora un corpo spirituale e perciò si è spogliato di tutte quante le altre qualità del corpo: non gli è rimasta gravità, né spessore, né alcun’altra passione del corpo: ma non si è privato delle piaghe, non ha eliminato le cicatrici, al contrario, per amore degli uomini, ha voluto amarle perché per mezzo loro ha ritrovato colui che si era smarrito, con quelle piaghe ha conquistato l’oggetto del suo amore”.
Il Dio Trinità ama l’uomo, ama ciascuno di noi di un amore folle, che ci svela nella croce del Figlio, il quale, anche da risorto, si compiace di portare come “ornamento” le ferite della sua passione d’amore, la sua passio charitatis. Avvolti da un tale amore, anche le esperienze più difficili della nostra vita e della vita della Chiesa e dell’umanità possono diventare occasioni di rinascita. Guardando il risorto ornato di ferite, anche noi possiamo considerare le nostre ferite come delle feritoie. Le ferite, accolte come feritoie, lungi dall’essere una condanna, possono diventare fonte di guarigione, opportunità per un cambiamento radicale dell’esistenza. Accogliere la ferita come una feritoia è un po’ come dire che le nostre potenzialità e le nostre forze si strutturano a protezione di quel nucleo fragile che costituisce la particolarità di ognuno, ciò che ci rende decisamente unici. Un giorno Silvano del monte Athos (monaco russo vissuto tra il 1866-1938) chiese a Gesù: “Signore dimmi che cosa devo fare, perché i demoni se ne vadano lontano da me”. La risposta che ricevette fu questa: “Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare”. E constata Silvano: “Da allora cominciai a fare così e l’anima mia ha trovato pace in Dio. L’anima mia impara l’umiltà dal Signore. Cosa incomprensibile: il Signore si è manifestato a me e mi ha ferito il cuore con il suo amore, ma poi si è nascosto, ed ora l’anima mia sospira per lui giorno e notte. Egli, pastore buono e misericordioso, è venuto a cercare me, la sua pecora ferita dai lupi, e mi ha guarito”.
Se portiamo, nello Spirito Santo, le nostre ferite come “ornamento”, diventeremo anche noi medici e curatori delle nostre anime ferite e di molte persone, anch’esse avvolte e segnate dalle ferite. Smetteremo di farci del male e troveremo nella nostra fede, una strada per rendere feconde le nostre stesse sofferenze. Continueremo a portarle in noi, non come “scarogne”, ma come un tesoro prezioso che ci pone in contatto con il nostro vero essere, con la nostra autentica natura divina. Afferma, in maniera stupefacente, Isacco il Siro, un monaco del sec. VII: “Beato l’uomo che conosce la propria debolezza (e la propria ferita), poiché questa conoscenza diviene per lui fondamento, radice e principio di ogni bontà. Quando infatti uno impara a conoscere la propria debolezza e la percepisce in verità, allora concentra la propria anima lontano dalla vanità che oscura la conoscenza e tiene in se stesso, come un tesoro, la vigilanza… L’uomo che è giunto a conoscere la misura della propria debolezza, è giunto alla perfezione dell’umiltà”. La donna consacrata è chiamata a testimoniare l’amore folle del Crocifisso, nelle sue ferite personali e nelle ferite dell’umanità. Le sue personali ferite, difatti, sono una risorsa nella testimonianza radicale del vangelo.
3.5. Dio Trinità si rivela all’uomo come luminosa bellezza
La profondità della vita del Dio Trinità trattiene un’ultima realtà: la bellezza. Bellezza che è tratto specifico della donna, in particolare della donna consacrata. Nel Cristo, Verbo eterno ed incarnato, rifulge la luminosità abissale del Dio tre volte santo. La sua stessa vita terrena è manifestazione della bellezza divina, che ha profondamente attratto e sedotto i discepoli, come direbbe il profeta Geremia (cf 20,7ss). Ripercorriamo brevemente la “via pulchritudinis” del Cristo, Verbo incarnato:
- la bellezza di una stella rivela ai Magi il luogo della sua nascita. Il Cristo è “Stella luminosa del mattino”, come lo chiama l’Apocalisse (22,16);
- la bellezza e l’autorevolezza delle sue parole attirano le folle, a differenza degli insegnamenti monotoni e ripetitivi degli scribi e dei farisei;
- la bellezza del suo volto, nell’evento della trasfigurazione, quasi tramortisce i tre discepoli, non abituati a contemplare una così stupefacente luminosità;
- la sua bellezza di pastore buono, o meglio di pastore “bello”, che attrae per il suo amore verso il Padre e per la sua compassione verso i poveri e di piccoli;
- la sua esaltazione sulla croce, che ha il potere di attirare tutti e tutto a sé. Quella sua “bellezza crocifissa” che si dà a vedere, come uno spettacolo, allo sguardo trafitto delle donne che lo avevano seguito da lontano (cf Lc 23,49). La bellezza travolgente della trasfigurazione, quando diventa, sul Calvario, “bellezza crocifissa” può essere paradossalmente avvicinata dallo sguardo umano delle folle e delle donne;
- infine, la sua paradossale bellezza di risorto, che, con la sua presenza/assenza, fa percepire la bellezza del Dio tre volte santo: il Padre, il Figlio e lo Spirito.
La bellezza del Cristo, pastore “buono” e “bello”, è una forza potente che attrae e atterra; è un evento carico di silenzio che nasconde, nelle sue pieghe fragili e luminose, lo stesso evento salvifico: la bellezza del Dio Trinità all’opera nella opacità e spesso nella bruttezza della vita degli uomini e nella forza, anche distruttiva, del cosmo intero. Il mistero salvifico, trattenuto nella bellezza della vita e dell’opera di Cristo Signore, ci permette di sondare l’esperienza che ciascuno fa di fronte alla bellezza. Quando la realtà si manifesta avvolta di bellezza, sembra che svaniscano tutte le mediazioni: ciascuno è semplicemente e irresistibilmente attratto dall’evento luminoso. La nostra sensibilità, la nostra vista, il nostro udito, il nostro odorato, il nostro gusto, il nostro tatto, quasi si perdono nella bellezza. E così accade della nostra capacità razionale, della nostra volontà, delle nostre emozioni superficiali o profonde. Il quel “frangente”, la realtà e gli eventi quotidiani sono percepiti quasi come “divini”. La bellezza delle “cose” e delle “persone” ci fa esclamare: “meraviglioso, splendido, celestiale, forte, bellissimo”. Parole tutte che attestano lo splendore di una cosa ordinaria, sia questa la soavità o la forza di un canto, i lineamenti di un corpo, l’armonia di un ambiente, il gusto di un vino d’annata, la bontà di un sigaro toscano o di una bistecca alla fiorentina.
Può apparire strano questo discorso. Ma proviamo a riflettere, nel silenzio del cuore, sull’esperienza che provoca la bellezza. Di fronte a un uomo o a una donna “bella”, di fronte a un paesaggio splendido e incontaminato, ciascuno, per un attimo, è immediatamente come traslocato nell’altro (uomo, donna, paesaggio). Quell’istante è un istante di profonda comunione; un istante che soprattutto oggi, per la nostra volontà di possesso, dura solo un momento. E’ sempre più frequente, sopraffatti dal desiderio di possesso dell’altro, non riuscire più a cogliere, nell’evento, la bellezza. La sequela di Gesù, pastore “bello”, ci permette di dilatare questo attimo di comunione. Di fatti, se la bellezza dell’altro ci avvolge e la bellezza del mondo ci seduce, la bellezza di Dio ci trasfigura. La bellezza dell’immagine di Cristo, che tocca la persona in Koinônia, ossia ciascuno di noi, ci sospinge nell’esperienza sensibile, psichica e spirituale, avvertita come dono e non come possesso; ci apre alla solidarietà con l’altro, che nella sua bellezza ci avvolge; ci fa sporgere sul mondo e sul cosmo per cogliere in esso la presenza di Cristo, Verbo del Padre; ci dischiude alla vita luminosa e trasfigurante del Padre, del Figlio e dello Spirito. La bellezza, in particolare la bellezza che il Cristo ci dona, racchiude davvero un mistero salvifico. Ci offre di passare dal possesso al dono, dalla chiusura alla comunione, da individuo a persona in Koinônia. La donna consacrata è chiamata a trattenere e annunciare con forza quanto diceva, con stupefacente verità, un personaggio di Dostoevsky: “il mondo darà salvato dalla bellezza”.
5. Conclusione
La bellezza di Dio Trinità, che risplende in Cristo, ci rende sui amanti e ci getta nel quotidiano con occhi e mani nuove, con mente e cuore puri, con anima e spirito rinnovati, per portare a tutti l’invito e l’esperienza del salmista: “Gustate e vedete come è bello il Signore” (cf. Sal 34,9). L’unica e autentica risorsa della donna consacrata è il Dio tre volte santo; quel Dio che, nella bellezza crocifissa del Verbo eterno e incarnato e nel fuoco bruciante dello Spirito Santo, si dona agli uomini come Padre. In questo orizzonte possiamo allora davvero concludere con una piccola storia, avvenuta nel deserto una quindicina di secoli fà, una storia che ha per protagonisti due monaci, uno anziano e l’altro giovane: “il padre Lot si recò dal padre Giuseppe a dirgli: Padre, io faccio come posso la mia piccola liturgia, il mio piccolo digiuno, la preghiera, la meditazione, vivo nel raccoglimento, cerco di essere puro nei pensieri. Che cosa devo fare ancora? Il vecchio alzatosi aprì le braccia, e le sue dita divennero come dieci fiaccole. Se vuoi, gli disse, diventa tutto fuoco” (Giuseppe di Panefisi 7).