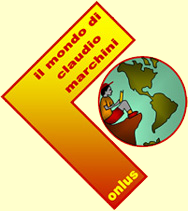Già solo la titolazione di questa festa che, quest’anno, sostituisce la domenica ci infastidisce.
Come si fa ad esaltare la croce? Il dolore non è mai da esaltare, né, è bene ribadirlo, ha in sé una valore positivo.
Davanti al dolore dell’innocente, davanti alla sofferenza inattesa, davanti ai tanti volti di persone che hanno avuto la vita stravolta dalla tragedia di una malattia o di un lutto, le parole diventano fragili e l’annuncio del Vangelo si fa zoppicante.
L’unica vera obiezione all’esistenza di un Dio buono, così come Gesù è venuto a svelare, è il dolore dell’innocente.
Molti dei dolori che viviamo hanno la loro origine nell’uso sbagliato della nostra libertà o nella fragilità della condizione umana. Ma davanti ad un bambino che muore anche il più saldo dei credenti vacilla.
Al discepolo il dolore non è evitato, e non cercate nella Bibbia una risposta chiara al mistero del dolore (Ma davvero cerchiamo una risposta? Noi vogliamo non soffrire, non delle risposte!).
Non troviamo risposte al dolore, troviamo un Dio che prende su di sé il dolore del mondo. E lo redime.
Per noi oggi, giunge l’occasione di una seria riflessione sulla croce.
Dio non ama la sofferenza
La croce non è da esaltare, dicevamo, la sofferenza non è mai gradita a Dio, Dio non gradisce il sacrificio fine a se stesso.
Lo dico per scongiurare la tragica inclinazione all’autolesionismo tipica del cattolicesimo, inclinazione che crogiola il cristiano nel proprio dolore pensando che questo lo avvicini a Dio, inclinazione che produce molti danni.
La nostra è una religione che rischia di fermarsi al venerdì santo, perché tutti abbiamo una sofferenza da condividere e ci piace l’idea che anche Dio abbia sofferto come noi. Ma la nostra fede non resta ferma al calvario, sale al sepolcro.
E lo trova vuoto.
La felicità cristiana è una tristezza superata, una croce abbandonata perché ormai inutile e questa croce, ormai vuota, viene esaltata.
È la croce gloriosa e inutile che oggi esaltiamo. Non quella sanguinante cui ancora vengono appesi mille e mille cristi sanguinanti e morenti.
Una croce che ha portato Dio, che è diventata il trono da cui ha manifestato definitivamente la sua identità.
La croce non è il segno della sofferenza di Dio, ma del suo amore.
La croce è epifania della serietà del suo bene per ciascuno di noi.
Fino a questo punto ha voluto amarci, perché altro è usare dolci e consolanti parole, altro appenderle a tre chiodi, sospese fra il cielo e la terra.
La croce è il paradosso finale di Dio.
Esaltare la croce significa esaltare l’amore, esaltare la croce significa spalancare il cuore all’adorazione e allo stupore.
Innalzato sulla croce (Giovanni non usa mai la parola “crocifisso” ma “osteso” cioè mostrato) Gesù attira tutti a sé.
Davanti a Dio nudo, sfigurato, così irriconoscibile da necessitare di una didascalia per riconoscerlo, possiamo scegliere: cadere nella disperazione o ai piedi della croce.
Dio – ormai – è evidente, abissalmente lontano dalla caricatura che ne facciamo; egli è li, donato per sempre.
E al discepolo è chiesto di portare la sua croce.
Ho scoperto che, spesso, la croce sono gli altri a procurarcela. O noi stessi.
E noi ci svegliamo ogni mattina e la carteggiamo e la pialliamo.
Evitiamo le sofferenze inutili, abbandoniamo i dolori che scaturiscono da un’errata visione del mondo!
Portare la propria croce significa portare l’amore nella vita, fino ad esserne crocifissi.
La croce non è sinonimo di dolore ma di dono, dono adulto, virile, non melenso né affettato.
Allora ti rispondo, amico che scrivi urlando a Dio il tuo dolore: alla fine della tua acida preghiera non troverai un muro di gomma, né un volto indurito ma – semplicemente – un Dio che muore con te.
E potrai scegliere di bestemmiarlo e accusarlo ancora della nostra fatica oppure – che egli te lo conceda – restare stupito come quel ladro crocifisso che non sapeva capacitarsi di tanta follia d’amore.
Tutto qui, tutto qui: la croce è l’unità di misura dell’amore di Dio.